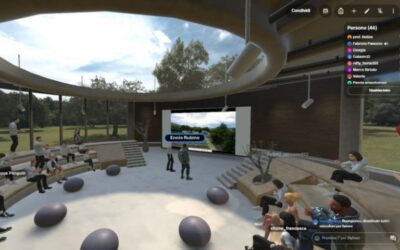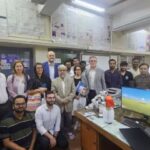Nuove scoperte di Sapienza Università di Roma sulla relazione tra ominini ed elefanti preistorici

Un nuovo studio di Sapienza Università di Roma svela come gli ominini arcaici interagivano con gli elefanti nel sito di Casal Lumbroso.
Una ricerca interdisciplinare per comprendere le interazioni tra ominini e grandi mammiferi
Uno studio condotto da Sapienza Università di Roma, in collaborazione con il Museo delle Civiltà, il CNR – Istituto di Geologia Ambientale e Geoingegneria (IGAG) e la Soprintendenza Speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma, offre un contributo fondamentale alla comprensione delle interazioni tra ominini arcaici e grandi mammiferi nel contesto europeo.
Le indagini sul campo, avviate nel 2017 e proseguite fino al 2019 sotto la direzione della Soprintendenza, sono riprese nel 2023 con una nuova fase di studio coordinata dalla Sapienza. Questa fase, di natura interdisciplinare, ha permesso di approfondire la conoscenza del sito di Casal Lumbroso, uno dei pochi al mondo a documentare l’utilizzo di carcasse di elefante da parte di ominini arcaici.
Casal Lumbroso: un sito archeologico di rilevanza mondiale
Attualmente, i siti noti a livello globale che testimoniano l’interazione tra ominini arcaici e carcasse di elefante sono meno di venti. Casal Lumbroso si distingue per la quantità di reperti e per l’approccio metodologico adottato dagli studiosi, che ha consentito di ricostruire in dettaglio la sequenza di eventi legata alla deposizione dei fossili e alle relazioni tra Homo ed elefante.
Durante gli scavi è stata rinvenuta una carcassa incompleta di elefante antico, associata a industrie litiche e a strumenti in osso ricavati dallo stesso animale. L’analisi tafonomica ha rivelato che l’elefante non fu soltanto una fonte di nutrimento, ma anche una preziosa risorsa per la creazione di utensili ossei.
Un ecosistema scomparso ma ricco di biodiversità
Oltre alla carcassa di elefante, i ricercatori hanno individuato resti di rinoceronti, bovini, cervidi, daini, caprioli e lupi, che attestano la presenza di un ecosistema ricco e ormai estinto. Queste scoperte forniscono una finestra unica su un mondo naturale complesso, popolato da specie oggi scomparse, e permettono di comprendere meglio l’ambiente in cui vissero gli ominini arcaici.
Le analisi scientifiche e la ricostruzione del paesaggio antico
Lo studio condotto dalla Sapienza Università di Roma e dai partner di ricerca consente di ricostruire eventi accaduti in un paesaggio preistorico, lungo il corso di un piccolo fiume, dove un gruppo di cacciatori-raccoglitori macellò un elefante e ne utilizzò le ossa per creare strumenti.
Specie come il Palaeoloxodon antiquus, oggi estinte in Europa, raccontano attraverso i loro fossili una storia di adattamento umano, trasformazioni ambientali e mutamenti climatici. Il progetto, frutto della collaborazione tra archeologi, paleontologi, geologi e specialisti di diverse discipline, integra analisi geologiche e stratigrafiche con indagini geochimiche sui sedimenti vulcanici, che hanno permesso di datare il sito a circa 400.000 anni fa.
Le analisi isotopiche e le condizioni ambientali del passato
Un ulteriore contributo è arrivato dalle analisi isotopiche effettuate su un dente di elefante, che hanno evidenziato la presenza di un ambiente forestato con clima caldo-umido. Questi risultati offrono nuove prospettive sull’ecosistema e sulle modalità di adattamento degli ominini arcaici, gettando luce su una fase cruciale dell’evoluzione umana in Europa.